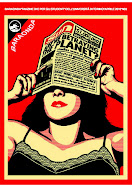[www.ilmanifesto.it] Forum sul presente e sul futuro degli atenei dopo la presentazione del disegno di legge Gelmini. E a pochi giorni dall'assemblea nazionale lanciata dai ricercatori precari e dalla Flc-Cgil. Il forum è stato condotto da Roberto Ciccarelli, Sara Farolfi, Benedetto Vecchi
Coniugare il bene comune con l'autonomia sociale delle persone, un nuovo Welfare del diritto alla mobilità, alla casa, al reddito con la lotta contro il precariato e una nuova politica per l'università e la ricerca. Sono i temi dell'assemblea nazionale convocata per il pomeriggio del 20 novembre prossimo dal «laboratorio» dei dottorandi e ricercatori precari dell'Onda e la Federazione dei lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil.
L'assemblea nazionale viene convocata da chi l'anno scorso si è riconosciuto nello slogan «L'Onda è irrappresentabile» e la Flc-Cgil. Su quali basi nasce questo rapporto?
Francesco Brancaccio. L'Onda è stata un movimento generale che ha parlato all'intera società e ha posto un problema politico al sindacato e alle forze politiche. Non penso che l'assemblea del 20 abbia lo scopo di riprodurre lo schema classico di una mobilitazione che chiede al sindacato di rappresentare istanze particolari. Il problema che abbiamo oggi è diverso. Dobbiamo costruire una mobilitazione larga che metta il sindacato davanti alla sua stessa crisi e, contemporaneamente, lo spinga a praticare delle aperture rispetto ai movimenti. Dobbiamo avere l'ambizione di aprire un percorso più generale di campagne tematiche sul terreno della formazione, del reddito e del nuovo Welfare. Il fatto che ci sia una convergenza su tale impostazione mi sembra un punto di partenza importante.
Giuseppe Allegri. Il rapporto con la Flc è nato nel corso dell'Onda. È una novità dopo anni di incomprensioni sui problemi della precarietà da parte della Cgil. È un rapporto dialettico che la Cgil, oggi isolata, dovrebbe raccogliere per investire sui lavoratori della conoscenza: docenti, ricercatori, scienziati, formatori, maestre e insegnanti, la vera ricchezza dell'Onda. Cosa non scontata, ma che le darebbe un ruolo innovativo anche rispetto al vecchio patto sociale e ancor più dinanzi all'afonia conservatrice della sinistra. Quanto ai movimenti si tratta di rilanciare le loro intuizioni sulla questione sociale, a partire dal reddito di base e dal nuovo Welfare, in cui il confronto con il sindacato è una parte utile.
Qual è stato invece il ragionamento che ha portato la Flc-Cgil a confrontarsi con i movimenti?
Francesco Sinopoli. Per noi non è una scelta casuale. La nascita della Flc è il risultato di un investimento che ha comportato forzature organizzative nella Cgil. I precari al nostro interno sono oggi più rappresentati rispetto a qualche anno fa. Questa situazione ci ha costretto ad innovare sia i contenuti dell'iniziativa sindacale che le pratiche del conflitto. Il confronto con i movimenti nasce dalla necessità di tenere insieme una riforma dell'università adeguata al bisogno sociale di sapere e un nuovo Welfare contro la precarietà. Oggi non è più possibile separare la formazione e la ricerca da un'idea complessiva del bene comune e della società. Nell'assemblea del 20 invitiamo chi vive nell'università a prendere parola, ma non vogliamo riprodurre le dinamiche corporative degli anni scorsi. Anche perché certe alleanze, quella con i rettori ad esempio, non si daranno più. Vogliamo provare ad andare oltre la lotta contro il Disegno di legge presentato da Maria Stella Gelmini e superare l'autunno con un percorso che metta insieme interessi diversi.
A differenza dell'anno scorso, la reazione contro il progetto della ministra Gelmini nel mondo universitario, come in quello politico, sembra ancora blanda. Avete l'impressione che si tratti di una riforma bipartisan?
Andrea Capocci. La riforma bipartisan è un tormentone che ci portiamo dietro da anni. In realtà non c'è mai stata un'opposizione di sistema contro le riforme. Del resto, sarebbe contraddittorio contrastare riforme che procedono in continuità da un governo all'altro. Più che dire però che c'è stata una risposta blanda, sottolineerei il fatto che la proposta di riforma è arrivata dopo un anno. La scelta del disegno di legge, e non del decreto, è una soluzione che prefigura tempi molto lunghi in cui il governo cercherà delle mediazioni in Parlamento. È la prova della capacità dell'Onda di praticare l'obiettivo, cosa che temo sia stata dimenticata da chi ha fatto parte del movimento. Se ancora oggi nel disegno di legge si parla dell'abolizione del ricercatore, questo è il risultato del movimento contro la riforma Moratti che ha fatto saltare il progetto cinque anni fa. Per questo non sarei così catastrofista sulla debolezza della risposta. La vedremo nel tempo.
Francesco Brancaccio. Sono d'accordo con Andrea: è stata la risposta dell'Onda ad imporre al governo di procedere con un più prudente disegno di legge. Il rinvio della riforma non ha fermato i tagli di 1,5 miliardi per l'università e di 7 per la scuola previsti dalla legge 133, ma ha comunque congelato l'azione del governo sull'università per più di un anno. Non perdiamo di vista che il Ddl è l'ennesima riforma a costo zero in un paese che non investe nella conoscenza e disprezza le intelligenze. Ciò non basta ad impedire a molti atenei, come la Sapienza, di adeguare i propri statuti prima ancora che la riforma diventi legge. La drastica riduzione del numero di facoltà per ogni ateneo viene fatta sulla base di presunti criteri di efficienza e produttività, laddove bisognerebbe semmai interrogarsi sulla crisi dell'attuale assetto delle discipline scientifiche. Tutto ciò impone una ripresa immediata delle mobilitazioni.
Francesco Sinopoli. Ho dei dubbi sul fatto che questa riforma sia bipartisan. Vorrei capire con quale altra parte sia stata concordata. Chi è stato fino ad oggi il responsabile università del Pd o dell'Idv? Rispetto al 2004 con la Moratti, si fa fatica a capire con chi dovremmo relazionarci all'interno dell'opposizione per fare, banalmente, un'audizione parlamentare. Questa situazione complicherà il lavoro. Non c'è dubbio però che sia avvenuto uno scambio con una parte del mondo accademico. Conferire poteri maggiori al rettore eletto solo dagli ordinari dice molto sul consenso che ha questa riforma. Così come il nuovo concorso che in realtà riproduce le solite logiche, non scalfisce il potere degli ordinari. C'è poi lo scambio con l'Aquis, il consorzio delle 13 università «virtuose» a danno delle università «improduttive», soprattutto meridionali, che ha spaccato il fronte accademico con la Conferenza dei Rettori (Crui). Ma questo non significa che l'accordo riguardi tutte le componenti dell'accademia. L'impostazione verticistica della riforma produrrà un assetto di potere che scontenterà molti, al di là dei precari e degli studenti.
A vostro parere il Disegno di legge affronta la situazione drammatica di un'università che ha mancato tutti gli obiettivi del processo di Bologna stabiliti 10 anni fa?
Cesare Gruber. La riforma Gelmini la ignora del tutto. Anzi, è un arretramento rispetto alla riforma Berlinguer del 1997. È molto italiana perché prospetta, fintamente, una sistemazione per migliaia di precari, ma blocca la formazione dei dottorandi attuali. Legarci in Italia con 10 anni di precariato, dopo i quali non c'è alcuno sbocco, significa negarci la mobilità ed isolare l'Italia rispetto all'Europa dove viene garantita.
Francesco Vitucci. Questa riforma non garantisce alcuna continuità di reddito per chi lavora da precario nella ricerca e manda avanti l'università. È irresponsabile perché danneggia l'autonomia del reddito che costituisce l'autonomia sociale dei singoli. Letteralmente folle è poi non prevedere un canale alternativo dopo i 6 anni di contratto a tempo determinato per i ricercatori. Se si vuole dare una stabilità secondo il merito, allora il merito deve premiare la produzione scientifica e culturale e non quello fiscale premiando gli atenei «virtuosi». Senza contare che il Ddl parla a malapena del dottorato e della necessità di cancellare i dottorati senza borsa.
Antonello Ciervo. Ricordo la finanziaria del 2000 del governo Amato che introduceva le Fondazioni nell'università. Avrebbero dovuto catalizzare investimenti privati, ma così non è stato. Le imprese, come nel polo farmaceutico di Chieti, hanno fatto «mordi e fuggi» e nel breve-brevissimo periodo hanno di fatto ritirato i fondi per la ricerca. Dove invece queste fondazioni sono decollate, hanno semplicemente posto in essere speculazioni immobiliari che sono servite per l'apertura di nuove sedi, magari pure decentrate.
Francesco Sinopoli. Quanto all'idea della Gelmini di introdurre nei consigli di amministrazione «almeno» il 40 per cento di esterni l'efficacia è tutta da dimostrare. Sono anni che si sente parlare di università aperte al territorio, ma ciò non è mai avvenuto. È l'elemento ricorrente in tutte le riforme. L'autonomia voluta dalla Gelmini si tradurrà in tanti Consigli di amministrazione con sedie vuote. Solo poche università codificheranno le relazioni già esistenti con l'impresa o le amministrazioni locali. Le altre andranno a mendicare. Avremo così un sistema di formazione più modesto, con una ricerca penalizzata che ricalcherà modelli aziendalistici non praticabili nel nostro paese, oltre che non condivisibili.
In questo disegno di legge, si parla tanto di valutazione. Voi cosa ne pensate?
Andrea Capocci. La valutazione è il caposaldo dell'ideologia bipartisan sull'università. Il suo obiettivo è di separare la riforma dell'università da quella del Welfare. Come ricercatore non posso non essere a favore della valutazione. Io lavoro per ampliare la conoscenza. Il problema è che se l'università di Milano riceve i fondi di quella della Calabria le disparità aumentano. Se invece si portano fondi in Calabria, allora si capisce che un sistema di valutazione va adottato in base ad una politica democratica. Un'altra cosa è valutare le università e, insieme, garantire il diritto alla mobilità, alla casa, al reddito, insomma un nuovo Welfare universalistico. Senza questa cornice, ogni valutazione diventa conservatrice. In un'economia della conoscenza, formazione, ricerca e Welfare sono la stessa cosa.
Ma è possibile misurare la produttività di un lavoro come quello della conoscenza?
Andrea Capocci. Non è solo difficile capire cosa significa produttività della ricerca, ma è altrettanto difficile capire cos'è produttivo nella trasmissione delle conoscenze. Spesso vengono separate, sebbene l'università faccia entrambe le cose. Nella conoscenza non esiste uno strumento di misura sganciato dall'obiettivo della misura stessa. Non si può definire prima cos'è la produttività, se non si sa a cosa serve una ricerca. In Italia non c'è solo il problema dei fondi. È che non esiste una discussione pubblica sulla ricerca, né sugli obiettivi che dovrebbe avere la nostra economia della conoscenza. Se non c'è questo, ogni valutazione vivrà in un vuoto pronto ad essere occupato da chi ha le armate più potenti.
Che idea di università esporrete all'assemblea del 20?
Antonello Ciervo. L'Onda non ha fatto solo una critica del potere dei baroni. Ha detto che oggi è in gioco l'università pubblica in quanto diritto. La sua idea di autoriforma ha sparigliato le carte rispetto ad un problema classico dei movimenti, il diritto allo studio. Autoriforma significa che l'università è innanzitutto un bene comune. E, in quanto bene comune, il movimento cerca di riappropriarsi dal basso dell'università in quanto luogo di trasmissione e di produzione del sapere. Su questa base a Perugia abbiamo conquistato consenso anche nel sindacato e nei partiti. Nell'Onda ha preso parola quello che con Sieyès chiamerei un nuovo «Terzo Stato», una soggettività che non ha nessun diritto ma che per questo paese è tutto.
Giuseppe Allegri. Magari fosse vero. Un terzo Stato dei lavoratori della conoscenza permanenti anche se retribuiti a intermittenza. Dopo 15 anni di precariato istituzionalizzato, questo terzo Stato capirà che le lotte corporative non bastano. La nostra generazione non può rassegnarsi a farsi ridurre all'invisibilità. Bisogna ridare dignità pubblica ad un'idea critica di università e di ricerca rispetto ai poteri.
Andrea Capocci. Penso che l'università dovrà diventare un centro erogatore di conoscenza che dia alle persone autonomia nel ciclo produttivo e una formazione permanente gratuita che sia un diritto e non un dovere per il lavoratore. Da quando l'Italia è diventata un paese postindustriale, scuola e università sono state inserite nelle reti dell'economia della conoscenza. Il problema è che questo è stato fatto al di sotto della soglia che permette l'autonomia. Fatto ancora più grave è che l'università non si è accorta di essere passata da un ruolo condiviso ad uno al servizio di un mondo produttivo che non vuole innovazione. Riacquisterà legittimazione sociale solo se smette di essere neutrale rispetto a questo processo. I saperi non devono essere trasmessi assecondando il ciclo economico al ribasso in cui l'Italia si trova oggi. I saperi devono essere usati come strumenti di opposizione e di garanzia sociale per il reddito. Se si esce dall'università sapendo usare solo un software della Microsoft, diventi precario nel giro di un anno perché sai fare solo quello. Chi invece ha competenze a largo spettro, da un'azienda se ne va perché sa riconvertirsi ed è meno ricattabile.
Francesco Vitucci. Parleremo di un'università della conoscenza che permette di avere un potere di innovazione, di non essere schiavi di chi ha bisogno solo delle tue mansioni e non della tua intelligenza, rispetto ad un'università della formazione che tende ad alleggerire l'impresa dai costi della formazione dei lavoratori che le spetterebbero. Questo è il punto.
Sette voci dall'università. Tra precarietà e indipendenza
Francesco Brancaccio è dottorando in Teoria dello stato alla Sapienza e partecipa ai «laboratori precari» della rete romana dei dottorandi e dei ricercatori precari. Giuseppe Allegri insegna a contratto Istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza e fa parte della Rete Nazionale dei Ricercatori Precari. Francesco Sinopoli fa parte della Federazione dei lavoratori della conoscenza (Flc) nazionale della Cgil ed è dottorando in Diritto del lavoro all'università di Bari. Andrea Capocci è borsista di postdottorato in Fisica alla Sapienza, fa parte dei «laboratori precari» romani. Cesare Gruber è dottorando in biofisica alla Sapienza e fa parte dell'Associazione dei dottorandi Italiani (Adi). Francesco Vitucci è dottorando in fisica alla Sapienza ed è membro dell'Adi. Antonello Ciervo è dottore di ricerca in diritto pubblico e partecipa al coordinamento dei precari dell'università di Perugia.